di Mariantonietta Losanno
Muovendosi tra il sublime simbolismo spirituale di Andrej Tarkovskij e Robert Bresson e l’odio tra le classi di Nagisa Ōshima e Rainer Werner Fassbinder, Kim Ki-duk è riuscito ad imporsi nel panorama cinematografico con un’idea di arte sfuggente – e che, dunque, seduce – intima, altera, violenta.
 “Ferro 3” è la storia di un uomo, Tae-Suk, che entra nelle case altrui non per svaligiarle ma per viverle nell’assenza. Rimane a “controllare”, aggiusta oggetti che non funzionano, lava la biancheria: se ne “prende cura”. Un giorno, entrando in una casa, si accorge di una ragazza (Sun-hwa) e dei suoi segni di maltrattamenti sul viso. Decide, allora, di prenderla con sé per vagare insieme nelle case degli altri (e nelle loro esistenze) e condividere quello “strano” modo di vivere. Il “Ferro 3” del titolo è il nome della mazza da golf meno utilizzata dal giocatore, impolverata nell’apposito contenitore. È anche il simbolo di un primo incontro “teneramente folle”, che si trasforma in una ripetizione ossessiva e in una dichiarazione d’amore. Kim Ki-duk stravolge quell’idea di “vuoto” riempiendolo. Tae-Suk e Sun-hwa vivono quel “vuoto” per colmarlo, per sentirsi parte di qualcosa. Per questo, scattano selfie con le immagini dei familiari delle case (sancendo, così, l’ingresso), compiono attività quotidiane (lavarsi i denti, utilizzare i vestiti degli altri) e si prendono cura di quello che trovano. Abitare, cioè risiedere in un luogo. “Starci”. Per sentire quel “vuoto” che è, in realtà, “pieno”. Di solitudine, di trascuratezza, di comunicazione. Lo stesso discorso vale per la quasi totale assenza di dialoghi. Il cinema di Kim Ki-duk, nonostante viva di sottrazioni, è “sovraccarico”. I discorsi di Tae-Suk e Sun-hwa vengono portati avanti con le espressioni e i gesti. Nonostante non parlino, condividono le loro paure; le richieste di aiuto che si rivolgono a vicenda si leggono negli sguardi e quei pochi dialoghi (come quelli dei proprietari della casa che, pensando di imbattersi in ladri utilizzano un linguaggio “duro”) disturbano perché – in parte – distruggono quell’idea di intimità e di “non-vuoto” che si nutre di simboli, pensieri invisibili, gesti. Non si tratta di mancanza di comunicazione, ma di “estetica del silenzio”.
“Ferro 3” è la storia di un uomo, Tae-Suk, che entra nelle case altrui non per svaligiarle ma per viverle nell’assenza. Rimane a “controllare”, aggiusta oggetti che non funzionano, lava la biancheria: se ne “prende cura”. Un giorno, entrando in una casa, si accorge di una ragazza (Sun-hwa) e dei suoi segni di maltrattamenti sul viso. Decide, allora, di prenderla con sé per vagare insieme nelle case degli altri (e nelle loro esistenze) e condividere quello “strano” modo di vivere. Il “Ferro 3” del titolo è il nome della mazza da golf meno utilizzata dal giocatore, impolverata nell’apposito contenitore. È anche il simbolo di un primo incontro “teneramente folle”, che si trasforma in una ripetizione ossessiva e in una dichiarazione d’amore. Kim Ki-duk stravolge quell’idea di “vuoto” riempiendolo. Tae-Suk e Sun-hwa vivono quel “vuoto” per colmarlo, per sentirsi parte di qualcosa. Per questo, scattano selfie con le immagini dei familiari delle case (sancendo, così, l’ingresso), compiono attività quotidiane (lavarsi i denti, utilizzare i vestiti degli altri) e si prendono cura di quello che trovano. Abitare, cioè risiedere in un luogo. “Starci”. Per sentire quel “vuoto” che è, in realtà, “pieno”. Di solitudine, di trascuratezza, di comunicazione. Lo stesso discorso vale per la quasi totale assenza di dialoghi. Il cinema di Kim Ki-duk, nonostante viva di sottrazioni, è “sovraccarico”. I discorsi di Tae-Suk e Sun-hwa vengono portati avanti con le espressioni e i gesti. Nonostante non parlino, condividono le loro paure; le richieste di aiuto che si rivolgono a vicenda si leggono negli sguardi e quei pochi dialoghi (come quelli dei proprietari della casa che, pensando di imbattersi in ladri utilizzano un linguaggio “duro”) disturbano perché – in parte – distruggono quell’idea di intimità e di “non-vuoto” che si nutre di simboli, pensieri invisibili, gesti. Non si tratta di mancanza di comunicazione, ma di “estetica del silenzio”.

I personaggi di Kim Ki-duk somigliano a quelli di Wong Kar-wai in “Hong Kong Express”: destinati alla solitudine, caratterizzati da un numero. Ancora di più, però, è l’idea stessa di cinema dei due registi a “collimare”: un cinema che ha l’aspetto di un sogno, che si focalizza su un concetto di amore che può essere dilatato, espanso, rallentato o bloccato, e su personaggi “senza nome” che si innamorano – anche solo per un momento – e realizzano che quell’innamoramento può avvenire “ancora una volta”. Un’idea di cinema che si “affanna” a rincorrere il tempo e a catturare i ricordi: un cinema potente, sensoriale, salvifico, che si mantiene in equilibrio tra intuizione e controllo e tra scena e montaggio.
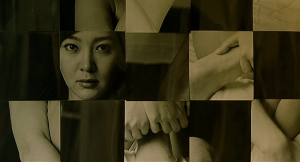
Il legame tra Tae-Suk e Sun-hwa alleggerisce le loro sofferenze. Su di una stessa bilancia il loro peso è zero, come se la somma dei loro dolori consentisse di annullarli. O forse di unirli, facendosi forza l’uno sull’altro, per fare in modo che si “incastrino” e acquisiscano un altro peso e un altro valore. Non è necessario comprendere se il loro legame sia reale o immaginario (“Difficile dire se il mondo in cui viviamo sia una realtà o un sogno”): è proprio il contrasto tra “ciò che appare” e “ciò che è” a costituirne il tratto caratteristico di un determinato modo (poetico) di raccontare la realtà da parte di Kim Ki-duk. Tae-Suk non vuole sottrarre oggetti, ma “parti di vita”, facendosene carico e dando nuova luce al suo amore che non è comunicabile e traducibile con le parole ma che è vivo, libero, sofferente. Tutto scompare nell’abbraccio – reale o ideale – tra Tae-Suk e Sun-hwa: si ammira la bellezza di una “rivoluzione silenziosa”, di una dolcezza impalpabile, di una presenza che si fa assenza e di un’assenza che si fa presenza. Per chi sa (ancora) guardare oltre, una “bilancia per due” è la possibilità di “sentire” l’altro in modo “intangibile”, è la capacità di emozionarsi, di avere cognizione del proprio dolore, di respirare. Restando in bilico tra l’astratto e il concreto, la poesia si fa immagine, il cinema si fa amore e l’amore si fa coscienza.




















